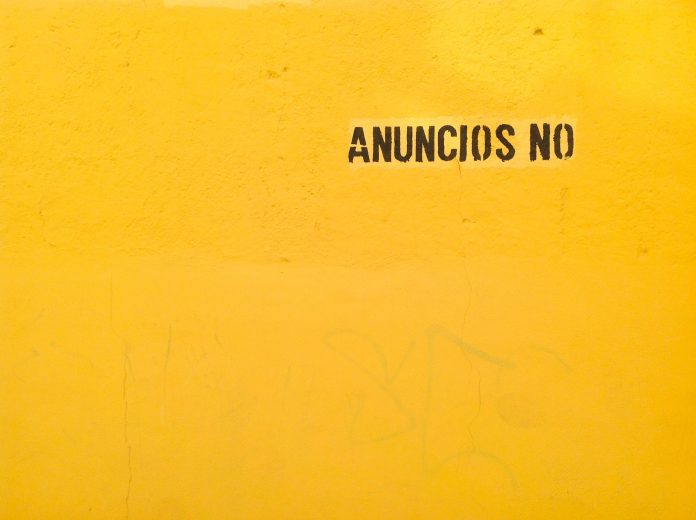La domenica in cui culmina la preferia, Sevilla improvvisamente sprofonda in un caldo torrido impensabile fino a pochi gorni prima. Per le strade non si vede anima viva. Il silenzio domina. Solo l’eco di posate dalle sanze oscure. Nessun proclama. Si aspetta una grande corrida (siamo nell’anno di gloria 2013) e il beniamino che non può deludere deluderà. Ma il silenzio non calerà sul torero, quanto sul rimpianto di una donna che ha fatto storia fra gli allevatori di tori. Questo stesso silenzio poi si frangerà nel puzzo di fritto con cui, nel recinto feriale, il desiderio di tornare a godere senza pensare a domani sta per dissolvere la sabbia di albero che ricopre polverosa i viali. Cavalli, stallatico, gelsomini, glicini, incensi, buio, sole abbacinante. Ogni momento sembra il primo e l’ultimo eppure se ne porta già appresso un altro, perché in questi giornie in questa città solo ciò che è effimero dura per sempre.
DOMENICA DI PREFERIA: SILENZIO IN CITTA’
Poi mi viene in aiuto Roma. Una Roma quasi seppellita. Inaspettata come questa domenica sivigliana in cui il sole alle tre del pomeriggio brucia a trentasei gradi, l’asfalto è rovente, le serrande abbassate. E soprattutto le strade sono deserte, gloria del vuoto di una città sostituita: chi cammina lo fa lungo il perimetro dell’ombra e dai portoni aperti sui patii ombrosi esce il fresco che fino a l’altro ieri era il freddo. Tutto è cambiato repentinamente e la città che articoli di giornale e voci del senso comune accomunano a Sevilla per approssimazione, mi è ricomparsa nella sua perfetta espressione desertica, solitaria, estiva. Per giorni le cose erano andate diversamente. Per trovare Roma avevo cercato i cespugli – qui rarissimi – di glicine in fiore. Ne ho individuati una decina, alla fine. I due preferiti in calle Quintana, dalle parti dell’Alameda, e ai Giardini del Murillo, vicino allo slargo di Cano y Cueto. A Quintana la cascata di glicine sommerge un terrazzo bianco, slabbrato, che pare in abbandono, sembra Centocelle. Al Murillo sembra una via romana dietro Villa Ada o accanto a Porta Maggiore. Il colore è quello. L’impressione è la stessa. Ma l’odore non c’è. Non conosco precisamente il motivo. Le zagare sommergono ogni cosa? O il glicine spagnolo è meno profumato? Propendo per la seconda, visto che il gelsomino non si lascia affatto vincere dal profumo debordante di azahar, mentre il glicine invece è semplicemente assente. Comunque stiano le cose, glicine o gelsomino, negli odori Roma è lontana, lontanissima da qui. Roma non la trovavo affatto, dunque. Restava immersa in quella dimensione nostalgica, materna. Finché non è arrivata tutta insieme la primavera di Sevilla, ossia una specie di pre-estate, la città si è svuotata quasi definitivamente per l’ultimo giorno di Preferia, e ecco Roma, all’improvviso, rovente solitaria suprema. Roma. E insieme a Roma, ecco spiegato un altro pezzo di quel che cercavo. Il silenzio.
Sembra una di quelle domeniche romane a fine luglio, infatti, quando la città è immobile, le strade sono ricoperte da un asfalto molle per il caldo e non si vede nessuno in giro, le spiagge sono piene, le piscine e i giardini scoppiano, ma le strade no, quelle sono deserte, niente automobili, niente autobus, solo qualche turista che arranca, qualche taxi. E un silenzio che non sai proprio come fare. Un silenzio pieno, come se si sentisse benissimo che la città è solo sospesa e che quella specie di assenza non è che il respiro dei milioni di anime che sono altrove. In quelle domeniche romane potete sperimentare davvero pienamente una dimensione del silenzio unica, assolutamente cittadina, in cui silenzio non significa tranquillità e i suoni che rompono il vuoto rimandano sempre a qualcos’altro, non a se stessi. Qui sta la più grande distanza da quella dimensione di vuoto che domina quando si è immersi nella natura. In campagna, il ronzio di insetti è ronzio di insetti. In montagna una campana che batte le ore è una campana che batte le ore. In città no. In città, in una città di deserto domenicale ogni suono rimanda a tutti gli altri suoni che nella quotidianità prevalgono. E quel che potete sentire è veramente il silenzio, il silenzio di tutti gli uomini e le donne che se ne sono andati. Sono loro, è merito loro, senza di loro non ci sarebbe questo vuoto.
Ora, tutto quello di cui sto cercando di parlare hanno potuto ascoltarlo con calma e per quasi un minuto intero i quasi settemila spettatori che ieri sera affollavano la plaza de toros della Maestranza, nel momento in cui si apriva una delle corride più attese della stagione taurina sevillana. Era la giornata della grande sfida: un uomo solo, un solo torero davanti a sei animali. Amatissimo da questa città, alicantino, figlio d’arte, José Maria Manzanares, vestito di luci nei colori acqua marina e oro, arrivava per il trionfo. Le spalle coperte da un passato che gli assicura fama eterna per essere stato l’unico capace di indultare un toro in questa plaza. L’unico che ha trovato la via per esaltare il suo animale, scoprirne il mistero e spingere il pubblico, il presidente e l’allevatore a ritenerlo degno di uscire salvo dall’arena per andare a coprire vacche e prolungare una stirpe che porti a lungo i segni del suo carattere. Entrava Manzanares, ieri sera, con l’attesa di una gloria ampiamente preconizzata nella serata di gala della stagione e quel che è capitato più tardi non è stato importante come quel che è capitato all’inizio. La corrida ha rispettato pienamente il detto spagnolo “Corrida de expectación, corrida de decepción”: poche idee del torero, pochi tori buoni, infinita delusione. Nessun successo è più infame di quello previsto, così pesante quando la previsione crolla, così intenso da spacciare anche il più potente degli uomini che si mettono in gioco. La corrida è andata male. Malissimo. Solo l’ambiente ha resistito a tutto. E la plaza stessa ha spinto il torero a toreare il suo ultimo toro, un piccolo animale che sembrava costruito a arte per esaltare l’uomo. Poi, la gente sciamava via, correva al bar di riferimento, gli uomini cercavano di specchiarsi nelle vetrine per vedere se erano ancora presentabili, le donne estraevano specchietti tascabili per rifarsi il trucco. E la serata è filata via. Ma, per il resto, tutto ha deluso come solo a una corrida si può essere delusi. D’altronde il minuto di grandezza era arrivato all’inizio. E quello nessuno avrebbe potuto dimenticarlo più. Erano le sei e mezza. Il sole ancora alto e caldissimo. I clarini suonavano e il torero ha attraversato l’arena nel paseillo cerimoniale, mentre i subalterni lo seguivano, i cavalli allungavano gli zoccoli stancamente, gli addetti ai muli e all’arena chiudevano la fila. Poi tutti si sono alzati in piedi e per un minuto, il minuto tradizionale di dolore, la plaza ha taciuto. Si sentivano soltanto i tintinnii prodotti dalle campanelle distribuite in corone festive sul dorso dei muli. E non erano i tintinnii che potreste sentire in campagna o dietro il recinto di un allevamento. Non richiamavano solo lo scampanellio. Rimandavano a altro. Ricordavano la donna scomparsa per cui tutti avevano smesso di parlare o di muoversi. Dolores Aguirre, allevatrice di tori.
Era lo stesso silenzio che immane invade ogni volta l’arena quando un toro sta per essere ucciso. Il silenzio che si pretende quando il torero è pronto a affrontare il cosiddetto momento della verità. Il silenzio che spacca Sevilla quando i pasos delle confraternite più austere attraversano la città durante la Semana Santa. L’improvviso mancare di ogni vocio, di chiacchiericci, battute, risate o scompiglio quando passa il Cristo del Gran Poder. La nullità sospesa e gonfia che si crea di fronte a una chiesa nel momento in cui la Vergine sta per essere partorita per la sua giornata di vita o quando sta per rientrare nel suo stesso feto per affrontare un altro anno di morte. Un silenzio che sembra aria ispessita da fumi di mancanza. La calma, la feroce controra, una specie di siesta per nulla infinita, una sospensione che si porta appresso tutti i presenti scomparsi, tutti quelli che erano a tavola a mangiare e si sono ritirati nelle rispettive stanze, e in salotto ora troneggiano posacenere zeppi, bicchieri sporchi, piattini con i resti di un dolce, ma non c’è altro, nessuno, niente di niente, silenzio. Lo ascoltiamo, lo soppesiamo, non ne veniamo a capo. Ma è inutile complicarsi la vita, perché quel silenzio non è affatto il silenzio della natura. Tutto qua. Basta ricordarsi ciò che si tira appresso. Ossia il respiro di tutti quelli che non ci sono, quelli che si sottraggono, che sembra si abbassino o si rimpiccoliscano di fronte al sacro, quelli che svuotano la città pronti a riempirla o che la lasciano per sempre.
E così sono andato alla Feria. Il portone sfavillante di colori troneggiava sull’odore che si espandeva intorno a baracchine fumanti, l’odore di tutte le feste spagnole. Un fondo di fritto, quel fritto in cui si friggono tutte le più pesanti leccornie del mondo, dalla frutta alle noccioline, da zuccheri in ogni consistenza alle almendras. E su quel fritto mescolato di ogni cibaria friggibile, un profumo appiccicoso e denso di zucchero filato e torroni, torroni dolcissimi, morbidi, torroni di Alicante, torroni di mare, talmente pesanti e dolci che a mangiarli al sole, davanti al mare, con un bicchiere di brandy in mano non si può far altro che ubriacarsi. E ubriachi erano già tutti. Padri e madri, nonni, nonne, giovani e vecchi. Arrivavano i clown per distrarre i bambini. Qualche ragazza ballava sevillanas. Qualche anziano parente applaudiva o si alzava in piedi a provare i passi che le giunture non permettono più. I bar delle casetas erano al lavoro. Qualche caseta pubblica era già aperta, alla faccia della norma che chiede di aprire solo dal lunedì di feria. ma non si poteva più aspettare. Non si poteva più. Mesi di freddo. Giorni e giorni di pioggia. E un anno intero a contare i giorni: aspettare che la festa vera cominci, apra, rompa in una rutilante atmosfera di colori, caldo, sudore, bicchieri di gin e ghiaccio, whisky e giaccio, coppe di brandy senza ghiaccio, coppe di Anis del Mono e ghiaccio. Basta che siano coppe possibilmente circolari. Basta che ci siano le telline di Sanlùcar de Barrameda, le alghe di mare di Cadice, i percebes delle scogliere più profonde, i pescettini, le torte, le tortillas, le torte di formaggio e prosciutto e le torte dolci e i dolci e i dolci più dolci che si possa immaginare, talmente dolci che sembra abbiano superato qualsiasi gradazione di dolce e che siano quasi amari, così amari da spingere dritti dritti tutti quanti i Sivigliani verso l’ubriachezza più dolce, amara e distruttiva. Lontano dal centro della Feria lunghe braccia metalliche portano ragazzini verso il cielo in urla spaventose, macchinine che si scontrano, aggeggi che lanciano verso il nulla. Un urlo compatto domina le strade intitolate agli antichi toreri sivigliani. Oggi è festa. Domani è festa. Ieri era festa. Sempre festa. Basta esserci. Perché qui è il centro del mondo. Dove si grida e si ride, mentre lontano, in città, domina nel caldo delle strade il silenzio di tutte le Vergini e i Cristi rinchiusi dentro le chiese.
*****
Le puntate precedenti:
1. Vigilia. Un venerdì qualsiasi nel nostro mondo
2. Domingo de Ramos. El sol es el mejor torero
3. Martedì Santo. Il cuore dei Misteri
5. Resurrecciòn. I costaleros di Achille
6. Pasqua. La reincarnazione del toro
7. Pasquetta. Il nazareno di Chaves Nogales