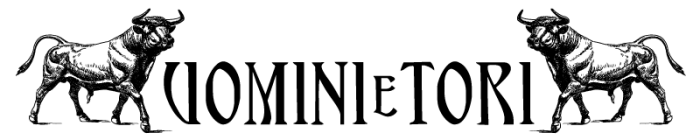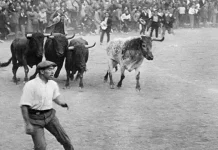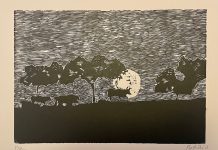Pomeriggi di solitudine (Tardes de soledad, titolo internazionale:Afternoons of Solitude – Francia, Portogallo, Spagna, 2024 – 125’), di Albert Serra; con Andrés Roca Rey, Roberto Dominguez, Francisco Manuel Duràn “Viruta”, Antonio Gutiérrez “Chacòn”, Francisco Gòmez, Manuel Lara “Larita”. Sceneggiatura: Albert Serra; fotografia: Artur Tort; montaggio: Albert Serra, Artur Tort; suono: Jordi Ribas; musiche: Ferran Font, Marc Verdaguer; produzione: LaCima Producciones, 3Cat, A Contracorriente Films, Andergraun Films, ICEC, ICAA, RTVE, Rosa Filmes, RTP, Tardes de Soledad. Concha de Oro alla 72ª edizione del Festival Internazionale di San Sebastiàn.
Per quanto tutto sia forse già stato detto e scritto vorrei aggiungere, parzialmente libero dai condizionamenti originati dal coinvolgimento emotivo, alcune riflessioni sul film Tardes de soledad, di Albert Serra. Dopo un paio di frustranti visioni casalinghe è stato necessario, e risolutivo, scoprire l’opera nella sua collocazione naturale: il grande schermo. Devo ammettere che inizialmente un’osservazione impoverita in dimensioni, colori e definizione, unita ad alcune resistenze tutte personali legate all’inevitabile trasporto di cui sopra nonché a una discreta conoscenza del mondo taurino, rendevano arduo affrancare lo sguardo a una visione oggettiva alimentando alcuni dubbi che oggi posso dire mal riposti. La scelta voluta e radicale di decontestualizzare la corrida, smembrarla, destrutturarla comporta un’inevitabile sensazione di straniamento trascinando lo sprovveduto spettatore in territori pericolosi e astratti (ma attenzione, Albert Serra non tradisce mai la consequenzialità del rito, per quanto la frammentazione si accentui con il procedere del film la destrutturazione di cui si parla, e che sicuramente viene percepita, è data unicamente dagli strumenti del linguaggio: chiudere gli spazi, appiattire le forme, sintetizzare l’azione e piegarla a nuovi ritmi). Il rischio concreto è quello di far nascere nei confronti dell’autore, sbagliando, l’infondato sospetto di un approccio colpevolmente, e furbescamente, voyeuristico.
Decontestualizzare la corrida è eliminare quanto c’è di rassicurante per chi, magari prendendo posto per la prima volta su quelle gradinate, può contare sulla rete di salvataggio generata dalle cento suggestioni diverse cui dedicare attenzione ogni qual volta ciò che avviene al centro della pista risulta insostenibile. Albert Serra sceglie di mostrare l’insostenibile.
Tardes de Soledad è un’opera d’arte cinematografica e come tale va accolta e interpretata. Se Albert Serra si prodiga con tutti i mezzi, tecnici ed espressivi, in un’operazione che riesce a essere contemporaneamente di svuotamento e accumulo, è per puntare dritto al cuore della tauromachia. In questo senso chi vi ha letto un tradimento dell’arte tauromachica non ha preso in considerazione l’impossibilità stessa di rappresentarla in contenitori diversi a meno di non sottoporla a un processo di trasformazione in cui un differente linguaggio diventi strumento possibile per restituire l’inenarrabile. Nessun intento di divulgazione quindi, nessun espediente estetico o drammaturgico già indagato, nessun intervento di montaggio utile a dirottare gli eventi sul territorio della spettacolarizzazione, nulla che possa aiutare a restituire uno spazio riconoscibile, assenza totale di qualsiasi clichè narrativo, bandita la retorica, il didascalismo e qualsivoglia stucchevolezza da teatro filmato. Dimenticatevi insomma tutto quel che è già stato fatto.
L’inquadratura compone lo spazio seguendo linee orizzontali e negando ogni parentela con l’iconografia tradizionale, la verticalità dell’uomo come unità di misura e ideale estetico non è contemplata, è una plasticità diversa quella che ci viene offerta dove tutto accade al di sotto dell’orizzonte chiuso della barrera e si sviluppa per linee parallele tra il dorso del toro e l’asta della muleta. Le parole che i subalterni pronunciano a più riprese e che solo nella lingua segreta della toreria assumono un significato pieno – onestà, verità – sembrano guidare le scelte formali del regista, naturalmente è solo un’illusione, il raffinato gioco di prestigio, cui il cinema ha da sempre fatto appello, prende corpo grazie a trecento ore di girato e mesi di montaggio estenuante. Cosa rimane quindi? Pennellate violente di colori abbaglianti nella luce di Madrid e Siviglia destinati a mutare in toni gravi sotto il cielo tragico di Bilbao, dettagli impietosi di morte e particolari rivelatori, suoni di tale cura ed efficacia da eccedere il reale grazie a uno staff tecnico in stato di grazia, voci che si accavallano in un delirio sonoro cubista e che richiamano costantemente al tempo, al ritmo, all’attesa, e naturalmente il volto teso di uomini ritratto in espressioni forzate di gioia o inquietudine trattenute, ma soprattutto ciò che mai era stato catturato da una macchina da presa con tale efficacia: animalità, trascendenza, rovesciamento dei ruoli. Tutto ciò a cui abbiamo potuto assistere solo in rari pomeriggi elettrici pervasi dal Duende o di cui abbiamo talvolta letto in pagine particolarmente ispirate viene offerto allo sguardo in modo nitido, inedito, sconvolgente.
Le quattro sequenze di combattimento – girate nell’ordine a Madrid, Siviglia, Bilbao e Santander – si alternano ad altrettanti momenti in cui la macchina da presa si ferma. Roca Rey viene inquadrato frontalmente quando, quadriglia al seguito, affronta in furgone gli spostamenti da e per l’arena, inquadrature in semitotale altrettanto fisse lo ritraggono nella stanza d’albergo. Non sono molte le parole che il protagonista ci concede, non resta che seguire i girotondi verbali dei compagni: slanci di adulazione, considerazioni curiose e un’atmosfera generale di cameratismo fanno da cornice alle espressioni a volte insondabili del Maestro di cui scrutiamo il volto impenetrabile come alla ricerca di un senso. È un tempo sospeso dove tutto è pervaso da un clima grave di ineluttabilità, in albergo ci si veste di luci, si soppesano le ferite, ci si affida alle immagini sacre. Tutto, in questi attimi di rarefazione, suggerisce il compiersi di una missione sacerdotale più che una discesa in battaglia. La solitudine del matador è naturalmente tutta interiore, evidenza sottolineata dal paradosso di vederlo costantemente assistito e accompagnato lungo l’intera durata del film. Il matador, quando non indossa il costume, è un uomo nudo, vestito e svestito come una bambola inerme o appena coperto dalla vestaglia sterile in uso nelle infermerie. C’è un particolare intermezzo inserito nel film: sono gli istanti che precedono l’inizio della cerimonia, il matador, con l’aiuto premuroso di un subalterno, aggiusta gli ultimi dettagli del capote de paseo e si mette in posa, un sorriso appena accennato, per una foto ricordo con un’ammiratrice, un arpeggio di chitarra lieve accompagna l’inquadratura, è un momento di dolcissima perfezione e bellezza.
L’autore, nella lunga serie di conferenze cui si è sottoposto e che a tutt’oggi stanno accompagnando la proiezione del film in Italia ed Europa, ha mantenuto un atteggiamento di equidistanza in relazione al tema eludendo domande spesso mal poste e riportando l’attenzione, come sempre dovrebbe essere, sull’oggetto cinematografico. Ne viene alla luce un equivoco di fondo: così come un critico, uno storico, un cinefilo non è tenuto a conoscere, e quindi capire, commentare, mettere in discussione l’arte tauromachica, allo stesso modo un appassionato ai tori, per quanto tempo e denaro abbia speso nelle arene d’Europa, per quanti libri abbia letto sull’argomento, non dovrebbe sentirsi automaticamente autorizzato a capire e criticare un film, a meno di non negare all’arte cinematografica, con qualche decennio di ritardo, peculiarità espressive proprie meritevoli quanto meno di un minimo approfondimento.
È solo, il mio, l’invito a fare un passo indietro e a guardare l’opera in prospettiva futura: se Tardes de soledad sarà ancora in grado, come penso, tra venti, trenta o cinquant’anni di proporsi come lezione utile nel dipanare l’eterna questione sul rapporto tra cinema e arte, se saprà ancora raccontare non tanto la tauromachia ma attraverso di essa qualcosa su di noi e sul mondo che abitiamo, allora Albert Serra avrà fatto centro e ogni giudizio oggi espresso non avrà alcun peso oggettivo. Per quel che riguarda l’atteggiamento distaccato e lapidario dell’autore – ma in rete potete trovare interventi più esaustivi – ci si può domandare se sia veramente compito di artisti e intellettuali, anche solo marginalmente coinvolti, difendere la corrida. Non so rispondere, di sicuro il dovere arduo e imprescindibile cui tutti dovrebbero essere chiamati in causa sta nel difendere non tanto la tauromachia quanto la sacrosanta libertà di goderne.
Un’ultima nota vorrei dedicarla alla sequenza d’apertura: esterno notte, un giovane toro è inquadrato a distanza ravvicinata – ne possiamo sentire il poderoso respiro, ne valutiamo la forza – lo sguardo, rivolto direttamente in macchina, pietrifica lo spettatore. È una bestia antica, riconosciamo immediatamente ciò che incarna e ciò che incarna ci toglie il fiato. Sarà solo molto dopo, quando per mano di un uomo la buia divinità lascerà il posto a un animale agonizzante e ferito a morte, che la paura cederà il passo alla pietà.
Il giorno in cui ci dovessimo accorgere di non provare pietà per il toro caduto e vinto dovremmo smettere di andare alle corride.